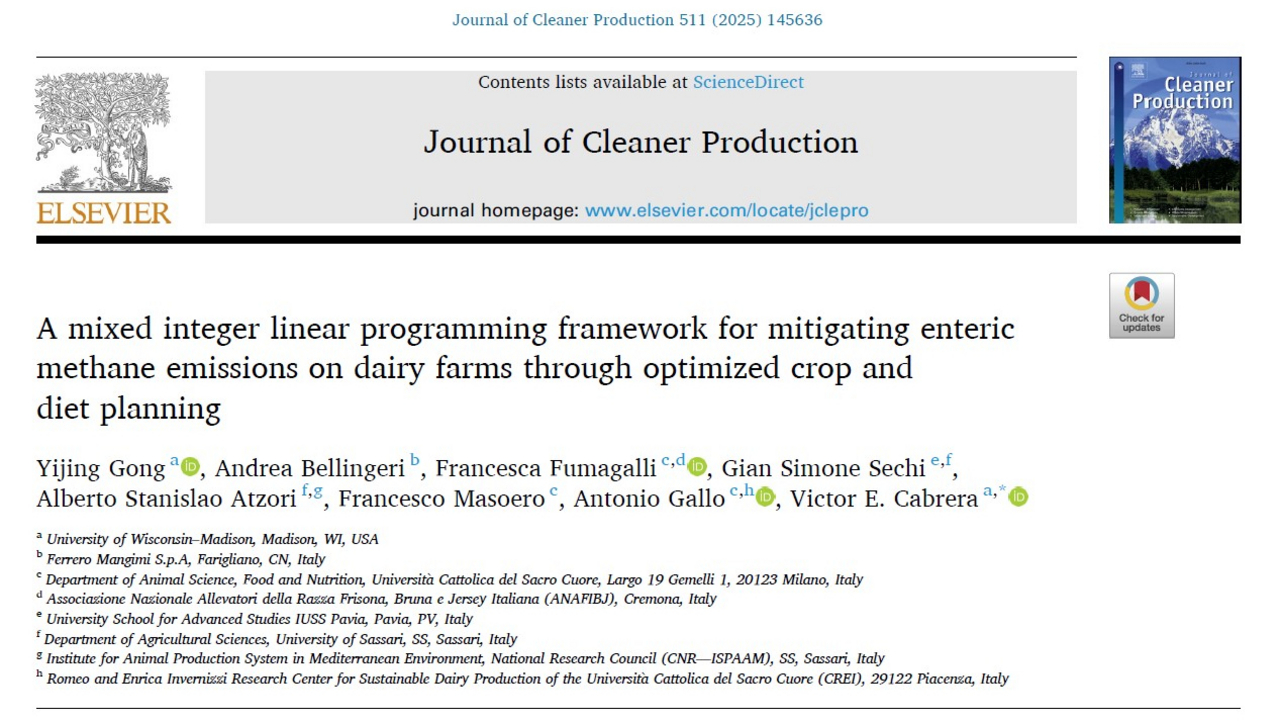Un gruppo di ricercatori internazionali, tra cui il professor Antonio Gallo del Dipartimento di Scienze animali, della nutrizione e degli alimenti e del CREI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha sviluppato un modello matematico avanzato in grado di supportare le aziende lattiero-casearie nella riduzione delle emissioni di metano di origine enterica, senza compromettere gli equilibri economici. Il lavoro, pubblicato sul Journal of Cleaner Production, risponde alle sfide poste dalla nuova Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea e dal crescente bisogno di mitigare le emissioni di gas serra.
Un doppio obiettivo: sostenibilità ambientale ed economica
Il metano prodotto dalla digestione dei ruminanti rappresenta una delle principali fonti di emissioni agricole. La nuova PAC 2023–2027 promuove la diversificazione colturale e pratiche più ecocompatibili, ma gli allevatori devono affrontare la complessità di bilanciare le esigenze nutrizionali degli animali, la pianificazione delle colture, la variabilità dei prezzi di mercato e le nuove normative ambientali.
In questo scenario, il team ha sviluppato un modello di Programmazione lineare mista intera (MILP) che riesce a integrare la pianificazione colturale con la formulazione della dieta per le vacche da latte rispettando i vincoli ambientali e normativi. Il modello si articola in due fasi: una ottimizzazione multi-obiettivo, che genera soluzioni Pareto-efficienti per esplorare i compromessi tra redditività e riduzione delle emissioni; e una fase di simulazione di politiche ambientali, con due scenari alternativi: TAX (tassazione sul metano) e RED (obiettivi di riduzione diretti).
Il caso italiano: tre aziende a confronto
Il modello è stato applicato a tre aziende lattiero-casearie italiane rappresentative: una standard (STD), una aderente al disciplinare Grana Padano (GP) e una per il Parmigiano Reggiano (PR). Le tre aziende condividono dimensioni simili ma differiscono per prezzo del latte, vincoli dietetici e regole colturali, permettendo di valutare l’efficacia del modello in condizioni operative diverse.
L’ottimizzazione ha mostrato una chiara relazione non lineare tra reddito e riduzione del metano: man mano che si sposta il focus dalla massimizzazione del reddito alla minimizzazione delle emissioni, il reddito diminuisce ma le emissioni si riducono in modo significativo. L’azienda PR, grazie al maggiore valore del latte (70 €/100 kg), ha potuto ridurre le emissioni con un impatto economico più contenuto (−6,4% per una riduzione del 7,4% di metano), mentre l’azienda STD ha subito una perdita del 58,4% per una riduzione analoga del 9%.
Tassare o limitare? I risultati delle politiche ambientali simulate
Il modello ha poi simulato l’effetto di due politiche ambientali:
1. TAX, che prevede una tassa sul metano emesso.
2. RED, che impone un obiettivo percentuale di riduzione delle emissioni.
I risultati indicano che la politica RED è decisamente più efficace. Anche con tasse elevate (fino a 16.100 €/tonnellata di metano, equivalente a 575 €/tonnellata di CO₂), la riduzione di metano si è fermata sotto il 5% per GP e STD, e poco sopra il 4% per PR. In più, l’effetto economico è stato drammatico: reddito negativo per l’azienda STD, e forti perdite per le altre.
Al contrario, l’approccio RED ha permesso di raggiungere riduzioni più significative (fino al 9,5%) con una minore erosione del reddito, soprattutto per le aziende ad alto valore del prodotto. L’analisi del “prezzo ombra” – ovvero quanto costa ridurre di 1 kg il metano emesso – ha rivelato che i costi aumentano rapidamente oltre il 2-3% di riduzione, sottolineando l’importanza di un’attenta calibrazione delle politiche ambientali.
Impatti sulle diete e sulla gestione aziendale
Per ottenere questi risultati, le aziende hanno dovuto modificare significativamente le diete animali, incrementando la percentuale di proteine grezze e riducendo la fibra. Questi cambiamenti hanno influenzato a loro volta le scelte colturali: in presenza di obiettivi ambientali stringenti, gli allevatori tendono ad acquistare più mangimi sul mercato piuttosto che coltivarli in azienda, a causa dei vincoli agronomici e nutrizionali.
Tali dinamiche mostrano l’interconnessione tra pianificazione colturale e gestione della mandria, e sottolineano la necessità di approcci integrati per affrontare le sfide della transizione ecologica in agricoltura.
Uno strumento per il futuro
Questo studio rappresenta un esempio concreto di come strumenti matematici avanzati possano supportare l’agricoltura nella doppia sfida della sostenibilità ambientale e della redditività economica. Il modello MILP proposto non solo fornisce soluzioni operative per gli agricoltori, ma offre anche elementi chiave per i decisori politici nella definizione di strategie efficaci e mirate.
In un settore come quello lattiero-caseario, dove le pressioni ambientali, normative e di mercato sono in continua evoluzione, strumenti di questo tipo possono fare la differenza tra una semplice dichiarazione di intenti e un cambiamento reale.